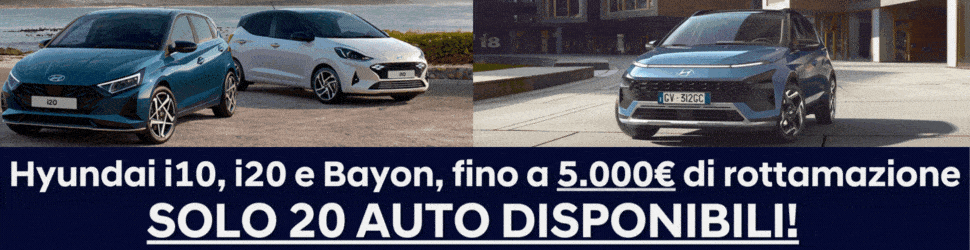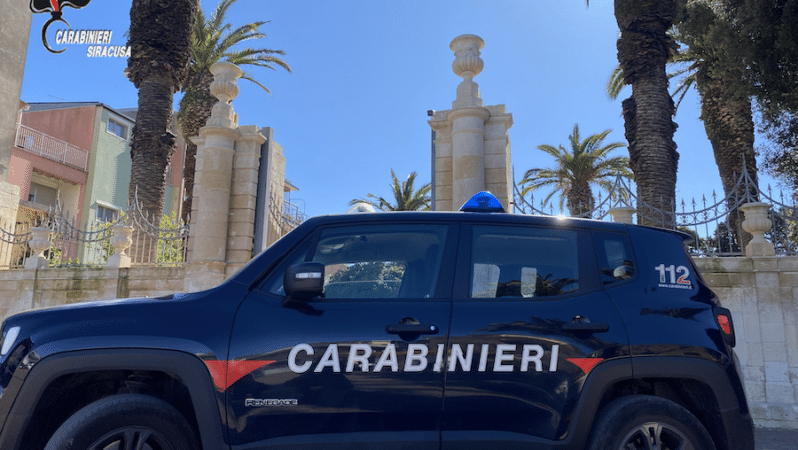Le giornate dedicate a Pantalica nei territori comunali dell’entroterra siracusano, in cui ricade il sito Patrimonio dell’Umanità riconosciuto nel 2005 (Cassaro, Ferla e Sortino), assumono una notevole rilevanza per le nuove proposte di intervento e un confronto sull’attuazione del piano di gestione del sito Unesco. Oltre alle comunicazioni delle istituzioni, degli amministratori locali e degli esperti del patrimonio naturale e culturale, che svolgono la loro attività di promozione, divulgazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali in questi territori, si è ritenuto opportuno inserire alcune relazioni scientifiche, che costituiscono la premessa per pervenire ad un approfondimento della conoscenza del patrimonio archeologico e paesaggistico di Pantalica e a un confronto sulla sostenibilità del turismo culturale nell’area archeologica e nel suo ambito territoriale.
In particolare, nei giorni 23 e 24 aprile sono previste quattro relazioni di archeologi ricercatori e docenti universitari che si inseriscono negli incontri su “La Necropoli di Pantalica, Patrimonio dell’Umanità” e “Turismo culturale e archeologico a Pantalica”. Nella giornata del 23, a Cassaro, come da programma, sono fissati gli appuntamenti con Massimo Cultraro e Massimo Frasca. Il primo ha per oggetto “Pantalica nell’età del Bronzo: capitale di un regno?”, il secondo “Pantalica e il mondo greco”.
Qui di seguito i rispettivi abstracts: “Pantalica, uno tra i siti più importanti della Preistoria in Sicilia, rappresenta uno straordinario esempio di centro emergente che alla fine del II millennio a.C. assume il controllo delle vie di comunicazione tra le vallate dell’altopiano ibleo e la costa. Un centro che mantiene i contatti con la marineria egea, anche dopo il crollo dei palazzi micenei, una realtà urbana di dimensione internazionale, come indicano il grande edificio noto come anáktoron e i materiali dalla densa necropoli.”
“La cultura di Pantalica, resa nota dagli scavi archeologici di Paolo Orsi, si sviluppa con continuità per circa sei secoli, dal tredicesimo secolo al settimo secolo a.C. Ci si soffermerà sulle due ultime fasi di Pantalica distinte da Luigi Bernabò Brea (Pantalica III e Pantalica IV), che si collocano nel periodo cruciale che vede la fondazione delle colonie greche nella Sicilia orientale (seconda metà dell’ottavo secolo a.C.). Saranno esaminati in particolare i rapporti di Pantalica con Siracusa prima e dopo la fondazione della città greca e gli effetti sulla cultura materiale indigena dell’impatto con il mondo coloniale greco.”
Nella giornata del 24 a Sortino, come da programma, sono previsti gli incontri con Massimo Frasca ed Eleonora Pappalardo, che si soffermeranno rispettivamente su “Pantalica e il suo paesaggio culturale” e “Turismo archeologico. Dalla risorsa all’offerta.” Questi gli abstracts dei loro rispettivi interventi: “Il sito archeologico di Pantalica è inserito in un paesaggio naturalistico quasi incontaminato, di grande interesse naturalistico ed etnoantropologico. Oltre alla grande necropoli sicula, indagata e studiata da Paolo Orsi e Luigi Bernabò Brea, che conta più di 5000 tombe dislocate in gruppi scenograficamente collocati sui fianchi delle profonde cave intagliate dai fiumi Anapo e Calcinara, nei territori limitrofi di Ferla, Cassaro e Sortino sono attestate altre importanti testimonianze archeologiche, che abbracciano un ampio arco di tempo, dalla preistoria all’epoca medievale.”
“Branca del turismo culturale, il turismo archeologico vive un momento di particolare vivacità e si inserisce all’interno di un panorama complesso in cui del turismo prevalgono le good practice; e il rispetto della memoria e del passato è posto al centro della costruzione di un sistema buono che punta al soddisfacimento del pubblico, da un lato, e alla conservazione delle culture materiali dall’altro. L’allineamento concettuale turismo/archeologia, tuttavia, è un processo di particolare complessità nel momento in cui si considera il turismo come un fenomeno essenzialmente economico. Di conseguenza, se da un lato il bene archeologico si configura come una risorsa autosufficiente per la quale non sono richiesti interventi strategici in termini di marketing che ne determino il valore agli occhi del visitatore, poiché il valore è insito nella sua stessa natura e le eventuali lacune strutturali altro non fanno che concorrere all’aumento del suo fascino, dall’altro il territorio che lo ospita, del quale esso costituisce risorsa interna, viaggia su un binario “altro”, avendo invece bisogno di una politica pianificata e programmata che lo trasformi in destination e che contempli la presenza del sito archeologico al momento dell’attuazione di strategie promozionali e fruitive.”
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni